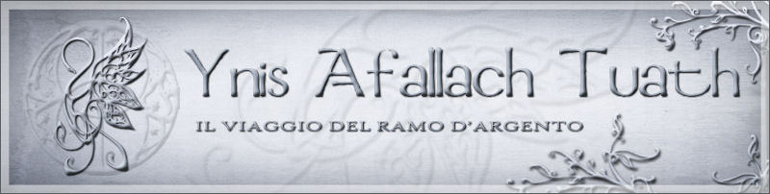|
|
I PILASTRI DELLA TRADIZIONE AVALONIANA
|
|
|
 |
|
|
Le Stazioni del Ciclo
|

Leggendo...
L'EMERSIONE E IL SUO ECO
E' tempo di emergere, di compiere la trasformazione e abbandonare tutto ciò che non è necessario.
|
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
Ynis Afallach Tuath |
|
| Storia dei Celti Britanni I |
|
| Mercoledì, 04 Novembre 2009 - 22:06 - 13948 Letture |
 |
Combatterono disuniti
e li unì la sorte della sconfitta.
Se fossero stati inseparabili,
sarebbero stati insuperabili.
Publio Cornelio Tacito a proposito dei Celti
(56/57 – ca. 117 d.C.)
LE LINGUE CELTICHE
I Celti apparvero nella storia documentata soltanto quando i Greci e i Romani iniziarono a scrivere resoconti su di loro, nei secoli VI e V a.C. Tali resoconti, che erano contrassegnati inevitabilmente dal pregiudizio e da incomprensioni culturali, descrivevano solo le ultime migrazioni dei popoli celtici a loro contemporanei, sicché per le epoche anteriori ci dobbiamo affidare necessariamente all'archeologia ed agli studi compiuti recentemente in vari campi.
Possiamo ipotizzare che, a un certo punto del loro sviluppo storico, i Celti parlassero una lingua comune, in un periodo immediatamente anteriore all’inizio del I millennio a.C., e che, subito dopo, si siano distinti due dialetti celtici, che vengono definiti Goidelico e Brittonico, o Celtico Q e Celtico P.
Il gruppo Goidelico è oggi rappresentato dal gaelico irlandese, scozzese e dell’isola di Man, il Brittonico dal gallese, dal cornico e dal bretone. Si ritiene che il Goidelico abbia costituito la forma più antica di celtico, mentre il Brittonico (che era legato strettamente al celtico continentale, chiamato gallico) si sia da esso sviluppato in un momento successivo. Soprattutto si è verificata la ben nota sostituzione della Q per mezzo della P nelle lingue del gruppo brittonico, la quale ha condotto gli studiosi a parlare appunto di Celtico Q e P.
Dal punto di vista linguistico, Henri Hubert e altri studiosi possono sostenere le prove archeologiche del fatto che i Celti fossero collocati in Britannia prima del 1000 a.C.
Quando i Celti compaiono nella storia documentata, vengono dai Greci in un primo tempo chiamati Keltoi. Polibio utilizza anche il termine Galatae (Galati), che ai suoi tempi era divenuto di largo utilizzo presso i Greci. Pare che il nome Galati fosse stato affibbiato ai Celti per la loro carnagione, in greco Gala significa latte, per cui Galati potrebbe significare "dalla carnagione bianca come il latte" (vedi la Via Lattea, la ninfa Galatea, e così via). I romani li chiamavano tanto Galli quanto Celtae.
E' pressoché certo che il termine Keltoi, era una parola di origine celtica. Alcuni, cercando di individuare il significato del termine, hanno richiamato la parola che significa “nascosto”, “nascondiglio” o “segreto”, da cui derivano il termine irlandese ceilt, e il termine inglese kilt. Quindi il termine Keltoi potrebbe indicare “il popolo nascosto”, o “il popolo segreto”, probabilmente riferendosi alla proibizione dei Celti di porre in forma scritta le loro vaste conoscenze. La storia, la filosofia, il diritto, la genealogia e la scienza presso i Celti furono trasmesse oralmente sino all’epoca cristiana, mentre per i documenti pubblici e privati usavano l’alfabeto greco. La motivazione del divieto di scrivere era dovuta soprattutto alla loro convinzione che la scrittura avesse prevalentemente un ruolo magico e che le parole scritte fossero troppo potenti, di conseguenza anche pericolose. Rimasto a quanto pare in vigore perfino dopo la conquista romana, questo rifiuto della scrittura in un ambito tanto essenziale, ha certamente contribuito a marginalizzare e disgregare la cultura celtica.
L’alfabeto ogamico è l’ultima scrittura adoperata dagli antichi Celti. Essa è attestata solo nelle regioni insulari: l’Irlanda, il paese d’origine, Il Galles, l’isola di Man, la Scozia e la Cornovaglia. All’origine questa scrittura criptica veniva forse usata per scopi magici, mediante l’impiego di bastoncini di tasso, un albero particolarmente venerato. Tuttavia, troviamo indizi dell’uso di tale scrittura anche nelle transazioni commerciali, oltre che nella delimitazione dei terreni. In quest’ultimo caso la si impiegava diffusamente, come attesta un frammento di telaio trovato nella torbiera di Lilttleton (contea di Tipperary).
Appare anche in stele funerarie databili tra il V e il IX secolo. Oggi sono inventariate circa 400 stele, di cui 350 in Irlanda, con una forte concentrazione sud-occidentale (contea di Kerry). Le stele bilingui, con versione latina in caratteri latini, sono state rinvenute soprattutto in Gran Bretagna.
Testimonianze di altri supporti sono eccezionali e tardive: il frammento di telaio ligneo già citato, una fibula d’argento e una ciotola bronzea da appendere.
LA BRITANNIA PRIMA DI CESARE
Popolazioni celtiche raggiunsero la Britannia, superando La Manica, nell'VIIII-VI secolo a.C. Dall'attuale Inghilterra meridionale si espansero in seguito rapidamente verso nord, colonizzando l'intera Gran Bretagna e l’Irlanda, sebbene nell'attuale Scozia sia sopravvissuto il popolo dei Pitti fino al X secolo.
Il nome dei Pitti probabilmente deriva dal latino pictus che significa dipinto, forse a causa della loro abitudine di pitturarsi o tatuarsi i corpi nudi.
I Britanni e i primi Gallesi del sud li conoscevano come Prydyn o Pryd.
L'evidenza di toponimi e nomi di persona suggerisce fortemente che i Pitti parlassero una lingua gaelica . I toponimi spesso ci permettono di dedurre l'esistenza di insediamenti storici dei Pitti in Scozia. Quelli con il prefisso Aber-, Lhan-, Pit- o Fin- indicano regioni abitate in passato dai Pitti (per esempio: Aberdeen, Lhanbryde, Pitmedden, Pittodrie, Findochty, ecc).
A sostegno di questa ipotesi, la tradizione gaelica asserisce che i Pitti fossero identici o discendessero dal gruppo brittonico che i Gaeli chiamavano, e ancora chiamano, Cruithne. Il termine Cruithne è verosimilmente imparentato con il gallese Prydain, e i gallesi sono i loro più diretti discendenti culturali.
Mentre l’elenco dei nomi dei re dei Pitti ci mostra una prevalenza di forme di celtico brittonico, dobbiamo precisare che fino al punto in cui gli storici riescono a retrocedere, la lingua comune dei Pitti era il gaelico. Ciò spiegherebbe anche la rapida integrazione del regno dei Pitti con quello dei gaelici Dàl Riada, che diede vita al regno unito di Alba (la moderna Scozia). Si narra che i Pitti vissero nell’Irlanda settentrionale e centrale per molti secoli: l’ultima testimonianza a riguardo compare negli Annali dell’Ulster nell’anno 809 d.C.
Sebbene sia rimasto poco di scritto dei Pitti, la loro storia, a partire dal tardo VI secolo in poi, è conosciuta da una varietà di fonti, comprese le vite dei santi (come quella di Columba di Iona, scritta da san Adomnán) e da diversi annali irlandesi. È dunque fuorviante e lontana dal vero l'idea, che hanno i più, dei Pitti come di un popolo oscuro e misterioso.
L’isola di Britannia, era divenuta famosa tra i popoli del Mediterraneo almeno nel V secolo a.C., grazie ai mercanti del mondo antico. Era uno dei pochi luoghi in Europa dove si potesse trovare lo stagno, necessario componente del bronzo. I Fenici e i Greci sapevano che sul versante nordoccidentale del mondo conosciuto si trovavano le “isole dello stagno”.
Attorno al 325 a.C, il navigatore Pitea originario della colonia greca di Massalia, l’odierna Marsiglia, compì un viaggio di esplorazione dell’Europa nordoccidentale, circumnavigò la Britannia e vide la vicina Irlanda, notando le caratteristiche principali del gruppo insulare.
I Greci le avevano chiamate Cassiterides, isole dello stagno, appunto. La radice britonica cassi, significa stima o amore, e compare diverse volte nei nomi propri. Si pensi a Cassivelaunos, “colui che ama Belinos”. Tuttavia l’opinione secondo cui il termine greco designante lo stagno sia di origine celtica dà adito ad alcuni dubbi: infatti la parola che in irlandese significa stagno è stan mentre in gallese è ystaen. Non è probabile che un termine che definisce un importante prodotto del mondo celtico possa essere scomparso dal vocabolario celtico, soprattutto se sostenuto dall’uso greco.
Polibio, Strabone, Avieno parlano delle isole dello stagno definendole Isole Pretaniche, suggerendo così che gli abitanti fossero i Pretani. Sembra che il nome sia stato dapprima utilizzato dai Galli e poi accolto dai Romani. Durante l’epoca romana, venne usato il nome Britanni, forse corruzione di Pretani, da cui derivò il nome Britannia. La forma più antica rimase in uso nei testi gallesi per descrivere l’isola di Britannia nel suo complesso – Prydain –.
Quando Cesare giunse in Britannia, il brittonico era la lingua universalmente parlata. Ancora oggi in Inghilterra, i toponimi celtici sono piuttosto comuni, nonostante le conquiste e le dominazioni di Romani, Angli, Sassoni, Iuti, Danesi, Normanni, e malgrado l’espulsione o l’estinzione dell’originaria popolazione. I fiumi e i corsi d’acqua hanno per la maggior parte nomi celtici, specialmente i fiumi più importanti, quali l’Aire, l’Avon, l’Axe, il Dee, il Derwent, il Don, l’Esk, l’Exe, l’Ouse, il Severn, lo Stour, il Tamigi, il Tees, il Trent e il Wye. La maggior parte delle alture più importanti e delle catene montuose ha un nome celtico, ad esempio i Pennini, e lo stesso vale per le foreste, come dimostrano Kinver Penge e Savernake. Ancora, alcune delle principali città, come Londra, hanno un nome celtico, mentre altre, come Manchester, lo mantengono in forma composta. Sussistono anche i nomi di alcuni territori, quali Kent, Thanet, Wight e Leeds. Sopravvivono anche alcune parole celtiche di significato topografico, quali cumb, coombe (valle), tor (collina), bourne (ruscello), carr (rupe) – si pensi a Carham –, luh (lago), si pensi a Lutton, Lincolnshire, e così via.
Se è vero che la cultura dei Campi di Urne diede vita alle prime società celtiche in Britannia, possiamo affermare che i Celti vivevano in Britannia già nel 1200 o nel 1000 a.C. Se inoltre è esatta la teoria degli studiosi del mondo celtico, tra i quali Henri Hubert, secondo cui il goidelico costituì la forma più antica di celtico, si può ragionevolmente ritenere che una forma di goidelico era una volta parlata in tutta la Britannia, ma che in seguito ebbe luogo un cambiamento di lingua con lo sviluppo del celtico P, noto oggi come brittonico.
Pitea narra che i Celti di Britannia erano agricoltori e pastori, come i loro cugini del continente. Coltivavano soprattutto il grano. In Cornovaglia egli vide i Celti lavorare il ferro, lo stagno e il bronzo, produrre ceramiche di qualità e lavorare come filatori e tessitori di lana e di stoffa. Egli poté constatare come ancora prediligessero il baratto. La Britannia infatti è stata l’ultima delle grandi regioni celtiche a battere moneta, le prime imitazioni degli stateri aurei di Filippo II di Macedonia, noti sia grazie all’attività di mercenari svolta dai guerrieri celti, sia ai contatti delle tribù galliche con le poleis greche del sud della Francia, furono prodotte in loco nell’80-70 a.C. è stata anche l’ultima a mantenere una monetazione autonoma prima della conquista romana.
Diodoro Siculo (morto nel 21 a.C.), citando alcune fonti più antiche, descrive con precisione il metodo di lavorazione dello stagno.
Gli archeologi hanno scoperto in Cornovaglia un’ampia varietà di prodotti di artigianato, che spazia dai fermagli iberici agli specchi greci, confermando l’esistenza di diffusi rapporti commerciali con la Britannia in epoca precedente all’arrivo di Cesare. In effetti a Publio Crasso, governatore romano della Spagna nel 95 a.C. circa, i Romani attribuivano il merito di avere reso più generalmente conosciuta la via marina che univa la Britannia sudoccidentale alle colonie romane in Spagna e di avere quindi sviluppato i traffici commerciali tra le due parti.
Ė stata avanzata l’ipotesi che verso il 1200-1000 a.C. il clima della Scozia cominciò a peggiorare, divenendo più freddo e più umido, incoraggiando in tal modo la produzione di torba e diminuendo il numero di terre arabili disponibili. Conseguentemente le comunità vennero spinte a proteggere i loro raccolti e il loro bestiame dalle incursioni cui facevano ricorso le tribù meno fortunate. Le scoperte archeologiche dimostrano come a partire da questo periodo si registri un numero maggiore di armi e di costruzioni di difesa. A partire dal VII secolo a.C. compaiono fortini attorniati da palizzate di legno, la cui datazione è stata consentita dal radiocarbonio; è difficile invece datare con precisione le fortificazioni in pietra a secco. I Celti della Britannia sia settentrionale sia meridionale utilizzavano il metodo della pietra a secco con grande abilità.
Molte delle loro magnifiche costruzioni sopravvivono: si pensi al villaggio di Chysauster, nei pressi di Madron, in Cornovaglia, che costituisce uno dei migliori esempi di abitazioni celtiche costruite in pietra, abitato probabilmente dal 100 a.C. al 250 d.C., costituito da nove grandi case circolari di pietra, oggi scoperte, ma un tempo protette da un tetto di torba o di paglia, alcune delle quali in buono stato di conservazione.
Rimangono più di cinquecento brochs, ossia di torri a pianta circolare e fortificazioni, in Scozia: le due più alte sono quelle di Mousa nelle Shetlands (che ancora si erge a un’altezza di circa ventitré metri) e di Dun Troddan (più di sette metri di altezza). Una delle più note è tuttavia quella di Clickhimin, che costituisce lo sviluppo di un insediamento agricolo fortificato, costruito attorno al VII secolo a.C.
Insieme a questi esempi riguardanti la capacità dei Celti di edificare durature costruzioni in pietra, rimangono anche molte testimonianze delle loro complesse e sofisticate alture fortificate. Una delle più note nel sud della Britannia è quella di Maiden Castle, nei pressi di Dorchester, il cui nome sembra derivare da Mai-dun, (la fortezza di Mai). Il sito esisteva già nel 3800 a.C., durante l’Età del Ferro divenne un’importante roccaforte e fu espugnata dalla II Legione Augusta, capeggiata dal futuro imperatore Vespasiano, nel 43 d.C. L'abitato originario, circondato da imponenti bastioni e intricate difese a salvaguardia delle due entrate laterali, era composto da capanne circolari, magazzini e luoghi di culto. Il suo accesso era consentito da un’articolata rete stradale. Sembra che questa fosse la capitale della tribù dei Durotrigi.
Anche a nord si trovano alture fortificate simili, e in certi casi uguali, a quelle del sud, come le fortificazioni Caterthun a Angus, note come Caterthun Bianca e Cathertun Scura, le quali distano circa tre chilometri l’una dall’altra.
All’epoca in cui Cesare iniziò a pensare alla sua conquista, la Britannia era un paese prospero, con fiorenti comunità agricole, progredita nell’arte, nella produzione di lana e di lino, nella lavorazione della ceramica a tornio e dei gioielli. I prodotti in lana erano persino esportati a Roma, dove possedere un sagum, ossia un mantello di lana britannico, significava essere alla moda. La civiltà britannica era anche avanzata per quanto concerneva la lavorazione dei metalli, la produzione del ferro, dello stagno e del rame, e anche dell’oro proveniente dal Galles. Anche l’arte della fusione del bronzo era notevolmente progredita. Fiorenti inoltre erano i rapporti commerciali con la Gallia e con il Mediterraneo.
L’arte aveva raggiunto in Britannia un notevole grado di sviluppo. Come quella dei Celti insulari in genere presentava fin dall’inizio le sue specificità, anche se dal V al I secolo a.C., era stata strettamente legata a quella continentale. Mentre tra i Celti del continente l’arte era all’epoca in declino, gli artisti celtici della Britannia negli anni tra il 100 a.C. e il 43 d.C., producevano magnifici specchi decorati in bronzo e altri oggetti, soprattutto smalti, fornendo così alcuni dei più belli e complessi esempi della precisione delle loro capacità artistiche. Perpetuavano, talora esaltandoli, i principi basilari dell’arte di La Tène antecedente agli oppida: perfetto adattamento delle decorazioni alla forma del supporto, uso sapiente e sistematico del compasso, ambiguità tra fondo e decoro, rappresentazione attraverso l’allusione, onnipresenza dei segni curvilinei. Grazie allo smalto multicolore alcune creazioni in metallo raggiungeranno una ricchezza cromatica fino a quel momento sconosciuta (placchetta smaltata di Paillard). Uno di questi specchi, ritrovato a Birdlip, nella contea di Gloucester, mostra sofisticatissimi intarsi smaltati nel manico, mentre lo specchio di Mayer, recuperato nel Tamigi, è semplicemente stupefacente. Come avviene per i manoscritti celtici miniati di epoca posteriore, è quasi impossibile paragonare questa forma di arte a qualsiasi altra.
Anche nella Britannia settentrionale esisteva una fiorente scuola di arte celtica, che aveva il suo centro a Dumfries, in Scozia, e che raggiunse il massimo sviluppo negli anni immediatamente successivi alla nascita di Cristo. Alcuni dei più begli esempi di arte celtica possono essere ammirati sui foderi delle spade in bronzo risalenti a questo periodo. Si pensi a quello trovato a Bugthorpe, nello Yorkshire.
Perché allora Cesare, nelle giustificazioni avanzate riguardo all’invasione della Britannia, ci dà una descrizione approssimativa del paese, ancora comunemente accettata oggi, nonostante sia in totale contrasto con altre fonti sulla Britannia più antiche e anche contemporanee, greche e latine?
Il progetto di invasione della Britannia era stato elaborato da Cesare già nel 57 a.C., quando egli stava combattendo contro la confederazione dei Belgi. Egli aveva scoperto che molti Belgi erano fuggiti in Britannia piuttosto che sottomettersi ai Romani. Essi asserivano di avere un legame di parentela con alcune tribù della Britannia meridionale, che si erano stanziate in quel luogo nel II secolo a.C. e che avevano mantenuto i contatti con i Belgi del continente. Alcuni capi in effetti rivendicavano la loro sovranità su tribù che avevano clan da una parte e dall’altra della Manica. Cesare così si ritrovò davanti a un capo dei Belgi, chiamato Commios (Commio) degli Atrebati, che avocava a sé la sovranità su una tribù di Atrebati della Britannia meridionale. Il generale romano si impegnò subito per conoscere quanto più che poteva della Britannia. Non si sa se i suoi informatori gli fornirono una descrizione incolore e assai inesatta della Britannia, nel tentativo di dissuaderlo dall’invadere quella terra, o se fu Cesare stesso a mutare il quadro delle descrizioni, o se ancora, era soltanto un soldato insensibile e non fosse la persona giusta per registrare accuratamente un certo tipo di dettagli.
HISTORIA REGUM BRITANNIAE, UNA FONTE STORICA CELTICA
Come già detto, I Celti di Britannia, come quelli d’Irlanda, iniziarono a narrare le loro tradizioni nella loro lingua soltanto nell’era cristiana. Se eccettuiamo quindi le tradizioni registrate in gallese, abbiamo poche notizie della loro storia anteriore all’arrivo dei Romani, a meno che siamo disposti a credere a Geoffrey di Monmouth.
Nel 1137 d.C. Geoffrey, uno studioso di origine celtica bretone, nato e residente in Galles, scrisse una cronaca in prosa in dodici libri, che aveva la pretesa di essere la storia della Britannia a partire dall’antichità: Historia regum Britanniae, Storia dei re di Britannia.
L'opera, dedicata dall'autore a Roberto I conte di Gloucester, ripercorre la storia dei re bretoni lungo un periodo di circa 2000 anni, da Bruto, discendente diretto di Enea (al quale si riconducono quindi le origini della dinastia bretone), fino all'avvento degli Anglo-Sassoni in Bretagna nel VII secolo. La sua popolarità nel medioevo europeo fu tale da giustificare l'affermazione per cui la Historia sarebbe il primo best-seller della letteratura inglese; in particolare, essa contribuì in modo fondamentale alla nascita della tradizione letteraria arturiana.
Per molti secoli nessuno mise in dubbio la sua autenticità di documento storico. Essa costituì la fonte delle Cronache di Raphael Holinshed (morto attorno al 1580), le quali a loro volta costituiscono la fonte di molti lavori di Shakespeare.
Geoffrey presentò l'Historia come un'opera storiografica e come semplice traduzione in latino di un non meglio precisato liber vetustissimus di cronache in gallese, fornitogli dall'arcidiacono Gualtiero, rettore del collegio dei canonici secolari di Saint George, a Oxford, in cui Goffredo si trovava.
Se questo sia da considerarsi vero è controverso. Alcuni studiosi hanno messo in dubbio che il liber vetustissimus sia esistito, o che Goffredo potesse avere le conoscenze linguistiche necessarie per tradurre dal celtico. John Morris in The Age of Arthur, per esempio, definisce la Historia un "falso deliberato".
Se il liber vetustissimus è un'invenzione, fra le fonti di Goffredo potrebbero trovarsi Nennio (al quale per qualche tempo si è scorrettamente attribuita la paternità stessa dell'Historia) e Gildas. Se invece il liber è esistito, l'opera di Goffredo rappresenta la prima trascrizione in latino di opere tradizionali celtiche brittoniche.
Tuttavia esiste una copia di un poema del XII secolo, scritto in esametri latini ad opera di Giovanni di Cornovaglia e intitolato “La profezia di Merlino”. Giovanni di Cornovaglia afferma che esso costituisce una semplice traduzione di un antico manoscritto cornico e fornisce note nella lingua cornica originale, con termini che risalgono al cornico antico. Vi sono alcune analogie tra “La profezia di Merlino” di Giovanni di Cornovaglia e il capitolo “Prophetiae Merlini” dell’opera di Geoffrey. Ė interessante notare che la Historia regum Britanniae presenta somiglianze con la tradizione irlandese in virtù del fatto che entrambe parlano di una stirpe di re che risalgono ai Troiani. Mantre Partalon è il Troiano che giunge in Irlanda per fondare una dinastia in seguito alla caduta di Troia, Brutus è il Troiano che si dice all’origine di una simile dinastia in Britannia.
Vi è poi un’altra analogia: nella tradizione britannica compare Dunwallo Molmutius, figlio di Cloten, re di Cornovaglia, che figura come colui che esercita la propria dominazione su tutta la Britannia, e che stabilisce il sistema legale divenuto successivamente noto col nome di “Leggi di Molmutius”. A lui è possibile collegare Ollamh Fodhla, che diviene re supremo d’Irlanda intorno al 714 a.C. e codifica il sistema legale Brehon.
Fra i sovrani di cui tratta l'Historia si possono citare: Bruto di Troia, figlio di Silvio e quindi discendente di Enea, fondatore della colonia di Bretagna, che da lui prenderebbe il nome; Leir, ovvero il Re Lear poi ripreso da Shakespeare, di cui non risultano menzioni antecedenti alla Historia; Cassivelaunos, re dei Britanni al tempo dell'invasione dei Romani di Cesare; Cunobelino, ancora fonte di ispirazione di Shakespeare per Cymbeline; Lucio, primo re cristiano di Britannia; il "Vecchio Re Cole" - l'Old King Cole citato da una popolare filastrocca inglese; Costantino I, primo imperatore romano cristiano; Vortigern, un famoso re protagonista di molte leggende medioevali. Ma il sovrano che emerge sopra ogni altro è certamente Re Artù, cui sono dedicati ben tre dei dodici volumi complessivi che costituiscono l'opera.
CESARE IN BRITANNIA
La sera del 24 agosto del 55 a.C. Cesare si mise in rotta verso la Britannia, con le legioni VII e X, in totale un contingente di 10.000 uomini, da Portus Itius (oggi Boulogne) per effettuare una ricognizione. Non avendo ottenuto nessuna informazione utile sull’isola e sui suoi punti di approdo, si fece precedere da due avanguardie: un ufficiale di nome Gaio Voluseno e da Commios, presso gli Atrebati britannici, affinché consigliasse loro di sottomettersi a Cesare. Cesare prometteva che, se essi avessero accettato, avrebbe riconosciuto Commios sia come loro capo sia come capo degli Atrebati di Gallia.
Entro le 9 del mattino seguente le navi erano ancorate nei pressi delle scogliere di South Foreland.
Lungo le cime della scogliera, erano radunati guerrieri britannici a perdita d’occhio, richiamati dall’allarme dato dalle sentinelle costiere non appena le navi erano apparse alle prime luci dell’alba.
Nel frattempo giunse Voluseno che riferì a Cesare di un luogo di approdo sicuro, tra Walmer e Deal. La terra era quella dei Cantiaci, ancora oggi ricordati nel nome della contea di Kent. Si trattava di una grande tribù divisa in quattro clan, i cui capi erano Cingetorige Carvilios (Carvilio), Taximagulos (Taximagulo) e Segovace. Essi avevano seguito i movimenti della flotta romana lungo la linea costiera con il loro esercito, che comprendeva anche robusti carri da guerra e cavalieri.
Dopo molte difficoltà e duri combattimenti contro le forze britanniche radunatesi per opporsi ai romani, gli invasori riuscirono a sbarcare nel Kent e a costruire un accampamento. Lì Cesare ricevette gli ambasciatori britannici che gli restituirono Commios, il quale era stato imprigionato al suo arrivo in Britannia. Le trattative non andarono però a buon fine e i britannici, approfittando delle difficoltà di Cesare (le navi con la cavalleria e le provviste erano state bloccate e costrette a tornare in Gallia da una tempesta), attaccarono di nuovo le forze romane, ma alla fine le armate di Cesare riuscì a metterli in fuga.
Dal punto di vista militare, la spedizione fu deludente per i Romani. Nonostante ciò, il Senato decretò 20 giorni di feste pubbliche per celebrare l’impresa quando ricevette il resoconto di Cesare.
Più di una volta dalla narrazione di Cesare emerge una nota apologetica, a sua difesa egli sostiene che si era imbarcato per una mera ricognizione militare, per mezzo della quale aveva perseguito lo scopo di conoscere il paese in vista di un’invasione su larga scala.
L’anno successivo Cesare era pronto per la sua seconda invasione In Britannia, comunque non si illudeva che la Gallia fosse completamente pacificata, in qualsiasi momento sarebbe potuta scoppiare un’insurrezione contro Roma, e in modo particolare durante la sua permanenza in Britannia si sarebbe potuto dare il via a una rivolta generale. Egli decise quindi di sventare tali progetti di sommossa portando con sé gli ostaggi gallici delle fazioni che si opponevano a Roma.
Tra questi c’era il capo degli Edui, Dumnorige, il quale ancora predicava l’utilità della cooperazione tra tutte le tribù celtiche di Gallia, al fine di scacciare Germani e Romani.
Sotto scorta militare, e accompagnato da un piccolo seguito di Edui, Dumnorige fu condotto a Porto Izio, dove fu raggiunto da altri capi gallici la cui lealtà a Cesare era allo stesso modo sospetta. Fu assicurato loro che essi sarebbero stati condotti in Britannia insieme alle forze romane in qualità di ostaggi.
Dumnorige disse che l'intenzione del romano era di uccidere lui e gli altri leader, Il giorno precedente quello previsto per la partenza della flotta d’invasione, ossia il sesto giorno del mese di Quintilis, che sarebbe poi stato ribattezzato Julius in onore di Cesare, Dumnorige e alcuni suoi seguaci riuscirono a sfuggire alle guardie romane, a impadronirsi di alcuni cavalli e a darsi alla fuga. Cesare mandò immediatamente la cavalleria al loro inseguimento, riuscì a bloccarli e ordinò loro di arrendersi, ma i Celti non avevano nessuna intenzione di consegnarsi, ci fu un combattimento, Dumnorige venne ucciso, e i suoi uomini tornarono al servizio del romano.
Dumnorige era un uomo di grande personalità, la sua morte era destinata a chiamare a raccolta il popolo di Gallia, che, nel volgere di pochi mesi, diede luogo a una guerra di liberazione che doveva durare quattro anni. Oltre a far precipitare gli eventi in Gallia, la morte di Dumnorige sortì anche l’effetto di arrestare i piani di Cesare di conquista totale della Britannia.
Per questo secondo tentativo di conquista dell’isola britannica, Cesare riunì una forza totale ben più consistente, per un totale di 30.000 uomini, per la precisione cinque legioni e duemila cavalieri, a bordo di 540 navi da trasporto e altre 200 imbarcazioni confiscate ai Galli.
A Tito Attico Labieno venne lasciato il comando della Gallia: gli furono affidate tre legioni e duemila cavalieri, e lo specifico compito di proteggere i porti allo scopo di assicurare a Cesare un ritorno sicuro.
La flotta partì il 6 luglio 54 a.C., insieme a Cesare andò Mandubratios capo dei Trinovanti (che compare nella Historia regum Britanniae col nome di Androgeo, figlio maggiore del mitico re Lud, nelle Triadi gallesi col nome di Afarwy, come uno dei "tre uomini della Britannia che persero il loro onore" per aver invitato Cesare a fare la sua invasione, e che inoltre si pensa sia stato la base storica della figura mitologica del dio gallese del mare Manawyddan).
Cesare aveva promesso di farlo re dei Trinovanti Britannici, e Mandubratios in cambio aveva accettato di fare da interprete e da capo negoziatore con i Celti di Britannia per conto di Cesare.
Lo sbarco avvenne nei pressi di Walmer, nome che fu assegnato alla località successivamente, in epoca sassone, e che significa "confine dei gallesi", ove "gallesi" è il termine sassone designante gli stranieri, e attribuito ai Celti di Britannia. I Britanni non opposero alcuna resistenza.
Cesare quindi sbarcò e scelse un posto adatto per l’accampamento (vestigia di questo accampamento sono state ritrovate nei pressi di un’antica chiesa a Walzer). Dopo aver lasciato sul lido a guardia della flotta dieci coorti (5.000 uomini) e circa 300 cavalieri (sotto il comando di un certo Quinto Atrio), marciò rapidamente verso l’interno per circa 12 miglia, trovandosi poco distante dal nemico.
Lo scontro che ne conseguì portò alla vittoria romana sui Britanni, i quali si erano arroccati in una posizione più elevata con la loro cavalleria ed i carri da guerra, in attesa di attaccare le truppe romane a valle.
Tuttavia, nella confusione, i capi dei Cantiaci e la maggior parte delle loro forze riuscirono a fuggire.
Il giorno seguente, arrivarono presso il campo del generale romano alcuni cavalieri inviati da Quinto Atrio per informarlo che nella precedente notte una grande tempesta aveva danneggiato quasi tutte le navi.
Era accaduto lo stesso incidente che aveva impedito a Cesare di conseguire la vittoria l’anno precedente. Egli ritirò dunque il proprio esercito nell’accampamento base. In seguito a un’ispezione si stabilì che quaranta navi erano danneggiate in modo irreparabile. Le altre vennero allineate sulla riva all’interno di una linea di difesa allo scopo di impedire che i Britanni potessero attaccarle.Esse dovevano essere riparate quanto prima. Nel contempo, venne inviata a Porto Izio una nave da guerra col compito di portare a Labieno l’ordine di approntare navi sostitutive.
Soltanto il 19 luglio Cesare riuscì ad avanzare con le sue truppe verso l’interno della Britannia, nel frattempo i capi dei Cantiaci erano entrati in contatto con Cassivelaunos, che assunse il comando supremo di tutte le tribù della Britannia meridionale. Aveva compiuto una marcia di solo pochi chilometri, quando le sue truppe dovettero fronteggiare in battaglia cavalieri britannici e carri da guerra. I Britanni di proposito si ritiravano e quando li avevano allontanati un po' dalle legioni, scendevano dai carri ed a piedi li attaccavano in modo diseguale, in questo modo il pericolo risultava identico per chi inseguiva e chi si ritirava, inoltre i Britanni non combattevano mai riuniti ma in ordine sparso, in modo che potessero coprirsi la ritirata e sostituire soldati freschi a quelli stanchi. Cesare perse uno dei suoi comandanti anziani, Quinto Laberio Duro. Secondo la tradizione britannica, registrata secoli dopo, fu Nennio, fratello di Cassivelaunos, che l’anno precedente aveva guidato l’attacco alla VII legione, a comandare questo assalto particolare. Tuttavia ci viene riportato che nel corso di questa battaglia Nennio fu ucciso.
Il giorno seguente i Britanni, che sembravano essersi ritirati lontano dal campo romano, decisero di attaccare a sorpresa le tre legioni e la cavalleria, che erano state inviate, sotto il comando del legato Gaio Trebonio, a fare provviste. I Romani riuscirono a respingere l'attacco nemico, provocandone numerose perdite, tanto da suscitare sgomento nelle truppe di soccorso britanne ed a indurle a ritirarsi.
Cesare ormai conosceva il nome del suo oppositore e sapeva dove era posta la sua capitale. Mandubriatos lo aveva ovviamente identificato come l’uomo che aveva sostituito suo padre, Inianuvetitios (Inianuvetizio), nel ruolo di sovrano dei Trinovanti. I capi dei Cantiaci ormai si erano convinti che la loro lotta e quella di Cassivelaunos contro i Romani li avrebbero portati soltanto alla sconfitta. I capi di cinque clan del sud e dell’est andarono all’accampamento di Cesare per discutere condizioni di resa. Attraverso la mediazione di Mandubriatos, questi capi diedero a Cesare informazioni militari di notevole valore.
Cesare condusse con grande rapidità l'esercito in direzione del territorio di Cassivellaunos, fino al fiume Tamigi, che passò senza dare il tempo al nemico di rendersi conto di quanto stava accadendo. L’altura fortificata dei Cassivelauni, presso Wheathampstead, racchiudeva un’area di cento acri, con bastioni che si ergevano sino a nove metri di altezza e la cui larghezza era di trenta metri. Le sue vestigia sono ancora oggi identificabili. Cassivelaunos era pronto a fronteggiare l’assedio dei Romani, ma i Romani presero d’assalto i bastioni su due lati con relativa facilità. Nella confusione, Cassivelaunos e alcuni uomini del suo seguito fuggirono. Cesare riuscì vincitore, e in più gli furono lasciati il bestiame e le provviste della fortezza.
Intanto Cassivelaunos, che conservava ancora un notevole potere, inviò un messaggero ai capi dei quattro clan dei Cantiaci, per ordinare loro di chiamare a raccolta i loro guerrieri e di sferrare un attacco all’accampamento di Cesare. I capi dei Cantiaci seguirono le sue istruzioni e riunirono un esercito che attaccò l’accampamento base a Walzer. Quinto Atrio mise in atto una risoluta difesa. Secondo la tradizione britannica Cingetorige venne catturato, mentre Cesare cita soltanto l’episodio della cattura di un capo di nome Lugotorige. Quinto Tullio Cicerone in una lettera al fratello Marco scrisse che questo attacco costrinse Cesare a tornare rapidamente al suo accampamento base, e che tuttavia lasciò la sua forza principale al comando di Trebonio, accampata attorno alla capitale dei Cassivelauni presso Wheathampstead. L’astuzia cui ricorse Cassivelaunos non ebbe quindi successo. Cesare restò a Walzer solo pochi giorni, assicurandosi che Atrio avesse la situazione sotto controllo, prima di ritornare a Wheathampstead. Cassivealunos si vide costretto, tramite Commios Atrebate, ad inviare ambasciatori a Cesare per trattare la resa.
Secondo il racconto di Cesare il fatto che Cassivelaunos fece ricorso a Commios come ambasciatore sembra suggerire che egli fosse stato tra i Cassivealuni e che gli Atrebati di Britannia avessero costituito una parte dell’esercito di Cassivealunos stesso. Commios era un sovrano imposto dai Romani e filoromano, ma non doveva essere impopolare, aveva governato gli Atrebati per un anno, ed essi sembravano soddisfatti della sua condotta di sovrano.
Cesare ordinò ostaggi e stabilì il tributo che era dovuto ogni anno dalla Britannia al popolo romano e impose a Cassivelaunos di non molestare né Mandubriatios né i Trinovanti. Il generale romano e le sue legioni portarono via con loro ciò che restava delle mandrie di bestiame dei Cassivelauni e un notevole numero di ostaggi: i primi degli innumerevoli Celti di Britannia che, per i successivi quattro secoli, sarebbero stati venduti come schiavi dai Romani, e che non avrebbero più rivisto la loro terra natale.
Ovviamente le ambizioni di Cesare riguardo alla conquista militare e all’annessione della Britannia non finirono a questo punto. Tuttavia, l’imminente rivolta della Gallia contro Roma avrebbe annullato tutti i suoi progetti: la Britannia avrebbe mantenuto la propria indipendenza per un altro secolo. Cassivelaunos riprese la sua posizione di preminenza tra i capi della Britannia e ignorò i termini del trattato stipulato con Cesare. Nessun tributo annuale venne pagato a Roma, né vennero inviati altri ostaggi. La Britannia tornò ad essere una delle più fiorenti tra le terre celtiche ancora indipendenti.
Fonti:
Peter Berresford Ellis (1998). L’impero dei Celti. Piemme
Chris Barber, David Pykitt (1997). Journey to Avalon: The Final Discovery of King Arthur. Samuel Weiser, Inc.
http://it.wikipedia.org/wiki/Britannia_(provincia_romana)
Note: Testo di Sylesia |
|
|
|
| Storia dei Celti Britanni I | Login/crea un profilo | 0 Commenti |
|
| | I commenti sono di proprietà dei legittimi autori, che ne sono anche responsabili. |
|
|
|
 |
|
|
![]()